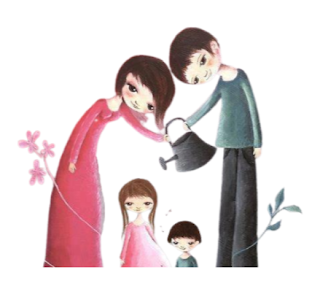Rimanere umili 😉
Qualche giorno fa si parlava a scuola proprio di questo: l’umiltà di chi è consapevole dei propri limiti e di chi cerca sempre di migliorarsi. Se ne parlava rispetto alla scuola, che dovrebbe essere bella proprio per questo: mi dà modo di conoscere nuove cose, di sperimentarmi nel confronto con gli altri e con i miei punti di forza e di debolezza.
Leggendo il mio solito quotidiano (Avvenire del 26/10/2023) mi imbatto in un articolo di MARCO VOLERI, che vi riporto, perché aggiunge altro a quanto ci siamo detti. So di non sapere e per questo resto disponibile ad aggiungere ulteriori tasselli al mio bagaglio culturale e umano.
Ammiro molto l’incoscienza di chi crede di sapere tutto o quasi.
Avete presente il classico tipo col sorriso smagliante e la verità nel taschino della giacca blu? Quando mi trovo davanti a personaggi che credono di sapere tutto, e di saperne più di te, mi chiedo sempre: “ma questo ci è o ci fa?”.
Scomodiamo Socrate e il suo famoso detto «so di non sapere», a lui attribuito attraverso Platone. Il filosofo racconta che la vera saggezza inizia con la consapevolezza della propria ignoranza. L’ignoranza qui non è da considerarsi come mancanza di conoscenza ma come il riconoscimento sincero delle nostre limitazioni nell’acquisizione di conoscenza assoluta. È il riconoscimento che il sapere umano è limitato, sempre in evoluzione, e che non possiamo mai pretendere di avere tutte le risposte.
Questa presa di coscienza può essere vista come umiltà intellettuale, virtù che ci spinge a porci domande, a cercare, a esplorare le diverse prospettive.
Credo però che il «so di non sapere» sia anche una chiamata all’empatia e alla comprensione.
Quando riconosciamo la nostra ignoranza diventiamo più aperti alla possibilità di metterci nei panni degli altri. Socrate credeva che solo attraverso il dialogo e l’ascolto attento fosse possibile sperare di comprendere gli altri e noi stessi.
Questo atto di mettersi nei panni degli altri non è solo un mezzo per apprendere dalle esperienze altrui ma anche per sviluppare una maggiore comprensione e compassione. Non so voi, ma per me il desiderio di conoscenza, che scaturisce dalla consapevolezza della mia ignoranza, è un motore pieno di cavalli per l’anima.
Sto studiando un’opera che credevo di conoscere già bene: quante cose non avevo notato prima, nonostante avessi approfondito la partitura in tante occasioni.
In un mondo spesso dominato da certezze inflessibili, «so di non sapere» ci invita a essere modesti nella nostra ricerca di conoscenza e ad abbracciare l’incertezza come una parte essenziale della vita.
Tempo che divora o tempo che vola?
La parola tempo viene probabilmente da una radice che indicava «tagliare», così come per analogia alcune misure di tempo vengono dal verbo latino «secare» (tagliare): secondo e secolo. Coerentemente le lancette (diminutivo di lancia) cominciarono a tagliare il silenzio per ricordarci che moriremo.
Ogni volta che l’uomo si allontana dal ticchettare di luce e buio, Cronos torna a divorare i suoi figli. Espressioni come «ottimizzare» ci illudono di esser noi a misurare il tempo e non lui a misurare noi, così ci abbandoniamo all’umanissimo miraggio di «guadagnarlo» accelerando o aumentando le attività. Definire il tempo in termini di «denaro», «spreco», «perdita» tradisce il fatto che oggi pensiamo di fermarlo con la «produzione». In realtà ciò che è sprecato e perso è l’io: chi sa chi è e che senso ha la sua vita, trova il suo tempo, anche se ne sperimenta la scarsezza. Non sente la necessità di doverlo aumentare e accelerare, ma lo accoglie grazie all’esperienza della «durata».
Nella Genesi le lancette non erano però così cruente: «Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra”. Dio fece la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. E Dio vide che era cosa buona».
Nella cultura giudaico-cristiana lo scorrere del tempo è perciò il regolare trascorrere della luce sulle cose, non la violenta lotta del mito greco. In quest’ottica il tempo/luce potrebbe forse riconciliarci con l’incalzante tic tac delle lancette: se ogni rintocco sprigionasse luce, il tempo ci sarebbe meno nemico.
La frattura tra luce e tempo è una ferita aperta nel corpo dell’uomo di oggi. Il consumismo frantuma l’esperienza del tempo come alternanza del giorno e della notte: le luci artificiali divorano il sonno. I primi a pagarne le conseguenze sono i ragazzi (da quando esistono gli smartphone, dormono in media un’ora in meno con conseguenze negative sulla loro salute psicofisica).
Il sonno è vita, non un carica-batterie, né, ancora peggio, una malattia, a cui presto la chimica risponderà diminuendone le ore, per averne di più per «fare» e «consumare». Dopare il tempo è un’illusione tossica.
Ogni volta che l’uomo si allontana dal ticchettare di luce e buio, Cronos torna a divorare i suoi figli. Espressioni come «ottimizzare» ci illudono di esser noi a misurare il tempo e non lui a misurare noi, così ci abbandoniamo all’umanissimo miraggio di «guadagnarlo» accelerando o aumentando le attività. Definire il tempo in termini di «denaro», «spreco», «perdita» tradisce il fatto che oggi pensiamo di fermarlo con la «produzione». In realtà ciò che è sprecato e perso è l’io: chi sa chi è e che senso ha la sua vita, trova il suo tempo, anche se ne sperimenta la scarsezza. Non sente la necessità di doverlo aumentare e accelerare, ma lo accoglie grazie all’esperienza della «durata».
Viviamo in modo frenetico non perché ci manca tempo, ma perché ci manca senso: i clacson suonano allo scattare del verde, il passo veloce aggredisce la strada, come se da quei secondi dipendesse la salvezza.
L’unico modo per non essere «tagliati» dalle lancette è sostare, che non è in-trattenersi, passare il tempo, ma in-dugiare, fare esperienza della durata: abitare il tempo.
«Abitare» è la forma frequentativa del latino «habere» (avere): chi abita «continua ad avere», è padrone, non servo. Non ha tempo chi non lo abita. Ma come si può indugiare in un mondo frenetico?
Il tempo acquisisce valore, non in base a ciò che facciamo, ma se siamo interiormente «servi» o «liberi» nel fare le cose. Per me preparare e offrire una lezione su Dante diventa tempo libero: faccio esperienza della durata, quelle ore aprono il tempo, lo vincono perché sono vive e piene di senso. L’«istante» diventa «stare in», indugiare e soggiornare, luminosa durata, e non ripetizione da cui fuggire. Qualsiasi cosa facciamo richiede tempo, e quel tempo è libero o servo in base al senso che gli diamo.
Il tempo lo si vince «contemplando», cioè quando si ripara la separazione di corpo e spirito. L’azione senza contemplazione diventa schiavitù: non occupa, pre-occupa. Con-templare ha la stessa radice di tempo: significava osservare un ritaglio di cielo, da cui la parola «tempio» (recinto sacro). Se il tempo non è un limite che apre sull’infinito, ci dilania: la trasformazione della domenica, da giorno di relazioni a giorno di acquisti, è una vera e propria vivi-sezione.
Luce e buio sono lancette per amare.
Si guadagna tempo solo amando, perché amare rende il tempo «durata». Accade quando il (ri-)taglio di tempo che ci è assegnato, decidiamo «liberamente» di impegnarlo per qualcosa o qualcuno che ci fa uscire fuori da noi stessi (il tempo libero è quello «liberato per» non semplicemente «da»).
Solo quando ci diamo anima e corpo, lo scorrere del tempo rallenta, anche se siamo impegnatissimi, perché a segnarlo non è il passo misurabile dagli orologi: il susseguirsi orizzontale dei secondi. L’amore apre la dimensione verticale del tempo, non misurabile, perché è durata: un secondo si dilata e diventa un secolo. Verticale è il tempo dell’artista impegnato nell’opera, verticale è il tempo della madre in attesa, verticale è il tempo delle relazioni vere, verticale è il tempo della preghiera, verticale è il tempo del lavoro appassionato, verticale è il tempo delle foglie più belle prima di cadere, verticale è il tempo delle carezze, verticale è il tempo del perdono, verticale è il tempo dato a un figlio o a un alunno anziché al cellulare…
Il tempo verticale non divora, ma vola: indugiando se ne perde il senso dello scorrere proprio perché se ne vive profondamente il senso dello scorrere, anima e corpo uniti. Diventa nostro, non ci può essere più strappato.
Il tempo c’è, siamo noi a scegliere per chi è. Il tempo è taglio che, per chi sa abitarlo, diventa tempio, invece resta tomba, pancia di Cronos, per chi lo subisce. Se diamo tempo, cioè senso, al tempo, ci stupiremo di quanta luce può sprigionare ogni ora, il tic tac segnerà il ritmo di ciò che dà vita non di ciò che la toglie, come accade alla scrittrice nel suo studio, perché il tempo, per chi lo abita, cioè per chi ama, non passa: dura.
Liberamente tratto da Alessandro D’Avenia nella Rubrica “Letti da rifare” del Corriere della sera del 3 dicembre 2018 (testo integrale cliccando qui)
La ragazza sempre in ritardo e la sua battaglia domestica
Una storia di scuola su cui riflettere.
Carolina arriva in ritardo a scuola. La rimprovero: «Sei al liceo, è ora di diventare responsabile!». Niente, il giorno dopo è lo stesso: la campanella suona alle 8:00, ma lei entra in classe alle 8:09, giusto qualche istante prima che l’ingresso della scuola venga chiuso. Io, da prof inflessibile, guardiano delle regole, parto in quarta con un’altra filippica: « Essere puntuali significa rispettare tutti, in primis te stessa. Le regole sono importanti, non sono vuote imposizioni. Servono a una positiva convivenza civile, al benessere di tutti, all’efficace organizzazione del nostro lavoro ». E via così: una lezione di educazione civica in miniatura. Una lezione evidentemente inutile, visto che la mattina dopo Carolina è di nuovo in ritardo. O meglio, è puntualissima nel suo ritardo, come un orologio svizzero: continua a entrare a scuola alle 8:09 per giorni, per settimane.
Carolina frequenta la seconda superiore. Ha lo sguardo duro, carico di sfida, messo in rilievo dal trucco marcato. Carolina è impermeabile: tutto le scivola addosso. Carolina sta in classe comunicandoti in qualunque forma non verbale che quello che tu, prof, stai proponendo, a lei non importa per nulla. Carolina, al cambio d’ora, parla solo di ubriacature, di pomeriggi al parco a spaccarsi e a spaccare, di fumo, di trasgressione così costante da diventare noiosa. Con Carolina non riesci a dialogare: se ci provi lei tace, ma non abbassa mai lo sguardo. Eppure Carolina è geniale: assorbe tutto, ha un’intelligenza vivacissima, un senso critico di raro acume. È una di quelle che quando discuti di un argomento ne coglie immediatamente il cuore e, le poche volte che ne ha voglia, ne parla in modo impeccabile. Ma Carolina gioca sempre al minimo. Anche quando prende un bel voto ti guarda dall’alto in basso, come se ti dicesse: « Hai visto? Sei contento adesso?» Come se si degnasse di farti un favore, così non le rompi più le scatole.
Mi fa rabbia, Carolina.
Perché spreca così le sue doti? Da dove viene tutta quella voglia di provocare chiunque? Me lo chiedo per mesi senza trovare risposta. Poi arriva il momento dell’Eneide. A mo il capolavoro di Virgilio: in classe gli dedico diverse ore, leggendo molti brani insieme agli studenti. L’Eneide è sempre un’avventura, un grande viaggio. Ma quando il viaggio inizia, fin dal proemio con l’ira di Giunone, Carolina scivola sul banco, chiude gli occhi e si addormenta. Le pagine del libro, con i loro versi immortali, diventano un improvvisato cuscino. I brani successivi non hanno risultati migliori. I Greci hanno distrutto Troia, l’hanno saccheggiata e le hanno dato fuoco. Il troiano Enea fugge con suo padre in spalla e suo figlio per mano, salpa con un gruppo di suoi concittadini superstiti. Enea riesce a superare molte prove, ma non l’indifferenza di Carolina, che continua a sonnecchiare con rare accezioni.
Una volta, ad esempio, Carolina è stranamente seduta composta, apparentemente attenta, ma intanto mangia popcorn. Le faccio notare che l’Eneide sarà anche bella come un film, ma non siamo al cinema. Mi fissa flemmatica: mette il pacchetto aperto sotto il banco e continua a mangiare di nascosto un paio di popcorn alla volta, appena distolgo lo sguardo. Quando finisco di leggere l’Eneide, racconto cosa accadrà dopo: i discendenti di Enea fonderanno Roma; dalla distruzione nascerà nuova vita, una storia inattesa. Ma Carolina intanto è già tornata a dormire.
Qualche giorno dopo assegno un tema alla classe. Provo a uscire un po’ dagli schemi, tento di provocare gli studenti. Chiedo loro di scrivere un elaborato con questo titolo: «Come l’Eneide ha parlato alla tua vita?».
Vedo alcune facce perplesse, provo a spiegarmi meglio: «La letteratura è sempre uno specchio. I classici sono immortali perché in essi possiamo trovare almeno un frammento della nostra vita. In quale frammento dell’Eneide vi siete rivisti?». I ragazzi cominciano a scrivere.
Carolina parte a razzo, è la prima consegnare. In un’ora buca mi metto in un angolo del grande tavolo della sala prof e comincio a correggere. Cerco apposta il tema di Carolina: sono curioso di leggere ciò che ha scritto, dopo aver dormito per tutta la lettura.
Il testo inizia così: «L’Eneide è il libro più bello che abbia mai letto». Sospiro: mi sta provocando una volta di più. Vado avanti: «Io Enea lo conosco di persona. Lo vedo tutti i giorni». «Ecco », penso tra me e me, «vedi l’effetto del consumo di cannabis di prima mattina? Entri a scuola sempre in ritardo e, al posto di vedere i compagni e i prof, ti sembra di vedere Enea».
Preparo la penna rossa per scriverle una nota sotto il tema: basta prese in giro!
Proseguo la lettura: «Lo conosco bene Enea, perché Enea è mia mamma». Mi viene quasi da ridere, non fosse per il fastidio. Poi leggo la frase dopo. E quella dopo ancora. Finisco il tema di Carolina senza fiato. Mi ritrovo a piangere come una fontana. Una collega mi affianca, mi chiede se va tutto bene. Le indico il tema. Lo legge, piange anche lei.
Questo è il tema di Carolina:
«L’Eneide è il libro più bello che abbia mai letto. Io Enea lo conosco di persona. Lo vedo tutti i giorni.
Lo conosco bene Enea, perché Enea è mia mamma. Mio padre è alcolista. Con il suo vizio, ha distrutto la mia famiglia, la mia spensieratezza, la mia infanzia e quella di mio fratello, proprio come i Greci hanno distrutto Troia. Ma, come Enea ha preso per mano suo figlio e l’ha portato verso un futuro diverso, lasciandosi alle spalle le macerie della sua città, così mia mamma ha preso per mano me e mio fratello, ci ha portati via dalle macerie di quella casa, ci ha regalato un futuro di nuovo possibile. Per questo mia mamma è il mio Enea. Il mio eroe. E, se un giorno diventerò madre, spero di essere una madre come lei ».
In un istante, la trasgressiva Carolina è diventata una maestra di vita. Mi ha ricordato che abbiamo tutti città distrutte alle spalle e futuri possibili davanti. Abbiamo tutti viaggi che ci aspettano, ripartenze necessarie. Mi sono chiesto, con dolore e con stupore, quante provocazioni degli adolescenti, che noi adulti vorremmo stroncare in nome della nostra presunta autorità, sono in realtà urla di dolore per ferite che non trovano voce. Quante volte tutti noi, adulti e ragazzi, ci barrichiamo dietro una finta durezza perché abbiamo paura di essere colpiti, di stare male? Quante volte chiudiamo le braccia per paura di essere pugnalati e perdiamo l’occasione di essere abbracciati?
Carolina è una persona meravigliosa, sensibile, empatica: adesso lo so, grazie a un tema.
Ripenso e auguro a me stesso e a tutti gli insegnanti, all’inizio di questo anno scolastico, di saper regalare ciò che ci appassiona a chi sta tra quei banchi; regalarlo, gratis, senza aspettarci niente, ma sempre col coraggio e con la speranza che spinge a guardare oltre, a quella città possibile da fondare oltre il mare.
Marco Erba, in Avvenire del 12/09/2023
Riprendiamo la scuola. Con grazia.
Il titolo non è sbagliato. Grazia non è una persona, quindi il minuscolo ci sta. Anche se, vista la sua importanza, questa parola richiederebbe la maiuscola. Di cosa parlo?
Come è capitato altre volte, attingo da un professore e scrittore che mi offre sempre spunti di riflessione.
La «ripresa» è ben diversa dalla «ripetizione»: riprendere è continuare a compiere e non reiterare.
La «ripresa» è ben diversa dalla «ripetizione»: riprendere è continuare a compiere e non reiterare.
Il ripetere fa scivolare nelle sabbie mobili dell’inerzia, quando si va avanti con la sola energia che resta quando la creatività si esaurisce: il dovere, una prigione da cui si cerca poi di evadere in modi più o meno estrosi e disastrosi. Un lavoro, un matrimonio, uno sport… vissuti solo per dovere soffocano. E dove non c’è più creazione di novità ma solo ripetizione, non c’è gioia. Diverso è «riprendere»: si riprende un film che amiamo anche se lo abbiamo già visto, si riprende un tramonto anche se avevamo ammirato quello del giorno prima, si riprende un’amicizia quando si continua il discorso da dove lo si era lasciato settimane prima… Ciò che si riprende non si ripete, è vivo, ciò che si ripete non si riprende, è morto. E infatti «ripetente» è sinonimo di bocciato e «mi sono ripreso» di salute: facciamo una «ripresa» quando vogliamo immortalare qualcosa da non perdere. Ma che cosa ci fa essere grati per ciò che ritorna senza che sia «ripetuto» ma «ripreso»?
Gratitudine, grazioso, grazia, gratis vengono tutti da un’antica radice che indicava ciò che dà gioia, qualcosa che riceviamo senza essercelo aspettato, e per questo interpretato come dono divino.
La grazia è questo: un dono elargito senza averlo chiesto o meritato, ma che inaugura in noi un modo di essere più vero, compiuto, luminoso. Una luce che non proviene solo da situazioni positive.
Il dono a volte può costar caro, eppure ci rende più autentici, compiuti, belli. La grazia non è un cosmetico che nasconde le rughe, ma le fa vedere piene di luce. La grazia è la chiamata a una bellezza compiuta, che riscatta anche le ferite.
Non dobbiamo confondere la grazia, il dono inatteso, con qualcosa di banalmente piacevole: è grazia ciò che ci fa avanzare, in modo inaspettato, nel cammino irripetibile che solo noi possiamo fare, anche se si tratta di soffrire.
Nel recente film Barbie, la donna di plastica, perfetta e senza difetti, è terrorizzata dal cambiamento: non conosce la grazia dell’essere umani, del crescere, del compiersi. In sostanza teme di soffrire, e invece c’è grazia anche nel dolore, non per il dolore in sé, ma perché, a usarlo bene, contiene il passaggio (inteso sia come apertura, sia come aiuto per far strada più rapidamente) a una forma di vita più piena e bella. L’aragosta quando deve crescere si nasconde, si spoglia della scorza rigida, rimane in carne viva fino a che non si forma una nuova corazza. È un momento di paura, nudità, dolore, ma necessario alla sua vitalità.
Per riconoscere una grazia bisogna chiedersi se ci porta a diventare più veri, belli e compiuti.
Dovremmo imparare a tenere gli occhi sempre ben aperti per saper ricevere le nostre grazie quotidiane, come afferma senza mezzi termini Cormac McCarthy nel suo ultimo romanzo, Il passeggero: «Nasciamo tutti dotati della facoltà di vedere il miracoloso. Non vederlo è una scelta».
Liberamente adattato da Ultimo banco, rubrica di Alessandro D’Avenia in Corriere della Sera, 11 settembre 2023 (vedi testo completo cliccando qui)
Il gran lavoratore e il pozzo
Si narra di un uomo conosciuto come un gran lavoratore. Il suo senso del dovere, la sua capacità di sopportare il pesante lavoro, la sua perseveranza nelle difficoltà, ne avevano fatto una leggenda, tanto che il governatore del paese in cui l’uomo abitava, lo additava a tutti come esempio di efficienza e produttività.
L’uomo era proprietario di un grande campo, che grazie al suo zelo divenne molto fertile, nonostante in esso mancasse l’acqua per irrigare. Nel campo non vi era un pozzo e la sorgente più vicina si trovana piuttosto lontana, così la maggior parte del lavoro quotidiano consisteva nel procurarsi l’acqua.
Ogni mattino, al sorgere del sole, questo uomo infaticabile si incamminva verso la sorgente con le sue taniche e, andando avanti e indietro tutta la giornata, riusciva a portare nel suo campo l’acqua sufficiente soltanto al tramonto.
Certamente egli riusciva a far fruttare il suo campo, ma si trattava di una situazione davvero pesante da sopportare, perché quasi tutta la sua giornata era impiegata solo per procurarsi l’acqua.
Gli amici che lo incontravano non riuscivano mai a instaurare un dialogo con lui, non solo perché egli non aveva mai tempo, ma anche perché il suo volto era sempre triste e abbattuto.
Un giorno, accorgendosi di essere giunto quasi allo stremo delle forze, consigliato dagli amici decise di scavare un pozzo nel suo campo; dopo mesi di fatica, l’uomo riuscì a terminarlo, ricavandone tanta acqua preziosa. Da quel giorno nessuno lo vide più andare avanti e indietro; anzi, lo si vedeva seduto accanto al pozzo con il volto radioso e sereno, circondato dai suoi amici con i quali dialogava felice, mentre essi guardavano a quella risorsa d’acqua.
Un vicino, incuriosito, una mattina si avvicinò all’uomo e gli chiese informazioni a riguardo del pozzo e di quella insolita gioia di vivere attorno ad esso. Il buon lavoratore rispose senza esitare:
«Ho scavato un pozzo profondo e, con mia grande sorpresa, ho trovato un uomo!».
A questa risposta il vicino rimase confuso e intimorito: non osò guardare nel pozzo, ma corse a riferire alle persone del villaggio più vicino quanto aveva appreso, così che tutti, in breve tempo, incominciarono a trarre le più disparate conclusioni a riguardo di questa strana vicenda.
Tutti dicevano: «Chi sarà mai quell’uomo ritrovato in fondo al pozzo?». Anche al governatore giunse la notizia, così mandò dei suoi subalterni dal gran lavoratore per avere più informazioni su quanto ormai tutti narravano di lui.
Quando egli li ebbe ascoltati, rispose così alle loro domande: «Sino a poco tempo fa passavo tutte le mie giornate camminando avanti e indoetro per portare l’acqua nel mio campo. Ma ora ho capito: chi troppo lavora non ha tempo per essere uomo! Tutto il mio tempo era solo per il lavoro. Il mio campo viveva grazie a me, ma io, come uomo, avevo smesso di vivere. Oggi che ho un pozzo tutto mio, ho ritrovato me stesso, ho riiniziato a vivere, ho trovato l’uomo che sono chiamato ad essere. Ho scavato un pozzo, ma ritrovando me stesso ho capito che il tempo ci è donato per vivere; e anche ho capito che la vita non ci è stata donata per riempire il tempo ma per ritrovare noi stessi nello scorrere del tempo!
D. Cogoni, Nella comunione della Santa Trinità, Cittadella Editrice 2023, pp. 13-15
Chi si prende cura di me?
Quando Franco Battiato canta La cura […] si rivolge innanzitutto alla propria anima, da anemos, vento, il soffio che rende «viventi» tutti gli esseri «animati», ma che in noi uomini è qualcosa di più.
A noi non basta essere viventi, noi vogliamo essere vivi.
Se i viventi hanno il fiato, noi abbiamo il respiro, che è quel di più: in italiano è lo spirito o spiro, da cui vengono parole come respiro, ispirazione, spirare… che racchiudono il senso della vita «animata» e non solo «animale». Ma mentre negli animali accade, noi possiamo aumentare questo soffio, tanto da riuscire, come dice il cantautore siciliano, a non soccombere a: paure, turbamenti, ingiustizie, inganni, fallimenti, dolori, sbalzi d’umore, ossessioni, malattie.
Ma qual è il segreto di questa cura di sé?
Che cosa ci guarisce veramente dalla paura del nulla, dal vuoto di senso che cerchiamo di riempire senza riuscirci?
[…] Chi può farmi sentire e dire «Amato sulla Terra», quasi fosse il mio vero nome? Può riuscirci un uomo o una donna? Posso riuscirci io? O ci vuole un’altra Cura?
Non è moralismo
La Cura è l’origine dell’umano nell’uomo.
Lo racconta un mito creato da Platone. Quando il dio Chronos (Tempo) che pro-curava tutto ai viventi dovette ritirarsi dalla vicenda umana a causa dell’inversione del corso del cosmo, gli uomini furono lasciati a se stessi e dovettero «prendersi cura di sé da se stessi».
Quando viene affidato a ciascuno (non siamo più del Tempo ma abbiamo del tempo) il tempo umano prende il nome di cura.
Nella narrazione cristiana addirittura l’Eterno si fa Tempo (carne) e si affida alle cure di una madre, di un padre e di un villaggio: anche Dio se entra nella storia umana ha bisogno di cura, e poi diventerà lui stesso uno che cura.
Essere «di» e «a» tempo significa «essere per la cura».
Non è un moralismo ma il modo umano di diventare vivi: noi non ci prendiamo cura degli altri perché li amiamo, bensì impariamo ad amarli se ci prendiamo cura di loro.
[…]L’amore allora non è qualcosa di spontaneo o naturale, un sostantivo, ma un impegno per rendere la vita dell’altro più compiuta, un verbo. E non lo faccio per filantropia, ma perché mi conviene: chi cura si cura, che è come dire chi dà tempo riceve tempo.
Non è un caso che il tatto, senso della cura, sia l’unico il cui mezzo è il senso stesso: la vista vuole la luce, il suono lo spazio, il tatto ha bisogno del… tatto. Io toccando sono toccato, curando sono curato. Avere «tatto» (cura) per la carne del mondo, dà origine all’amore di cui abbiamo bisogno per poterci dire Ama(n)ti sulla Terra. E la cura è il dono del tempo limitato che ho, io sono tempo fatto carne: curare è dare la carne, tras-curare è toglierla.
[…] L’inferno più profondo è fatto di uomini che mangiano altri uomini e il Satana di Dante ha tre bocche con cui divora costantemente tre dannati.
Noi, tempo finito che attraverso la cura diventa amore, spesso preferiamo pro-curarci il tempo togliendolo agli altri, «mangiandoli»: usandoli, manipolandoli, distruggendoli, crediamo di «assimilare», come con il cibo, il tempo che ci manca.
Per la fame di tempo ci sono due possibilità: la cura, sfamare, o il potere, sfamarsi e affamare. Però il potere dà solo l’illusione di aumentare il tempo, perché tempo e potere appartengono a piani di realtà che non si toccano: il potere fa sentire di avere presa sulla vita ma in realtà non le aggiunge un secondo.
Evoluti ma cannibali.
Sullo stesso piano del tempo – il mito platonico e il racconto evangelico lo mostrano – c’è invece la cura che, diventando amore, rende il tempo talmente pieno di senso che non si teme più di non averne abbastanza. Quando mi prendo cura della mia amata io sento di trasformarmi: il tempo suo e mio aumenta e non mi può essere più tolto, anche se apparentemente mi sembra di averlo «perso».
È il paradosso evangelico: «Chi dà la sua vita la trova, chi la trattiene la perde».
Ma dove trarrò le energie per curare senza sfinirmi? E poi chi si prende cura di me senza stancarsi? Non la Natura, ignara di me, ma il Dio a cui abbiamo rinunciato, finendo con il divorarci in proporzioni mai viste nell’ultimo secolo: noi, i più evoluti e progrediti, siamo diventati anche i cannibali peggiori nella storia. Dostoevskij lo aveva detto: «senza Dio tutto è possibile», perché senza essere curati non si sa come sfamarsi.
Abbiamo rinunciato al Soffio che Cura ogni cosa.
All’inizio di Genesi, prima che cominci la creazione, si dice che «lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque», e il verbo significa letteralmente «covare», e le acque, non ancora create, sono un modo di dire «caos». Questo Respiro «cova» ogni cosa, se ne prende cura perché diventi se stessa.
È solo una favola consolatoria o c’è qualcosa di vero? Bisogna farne esperienza, questa per me è l’unica via, anche perché tutte le altre, dettate dalla fame, non funzionano: successo, soldi, potere hanno sempre «respiro corto» e portano con sé «affanno». O troviamo ogni giorno il tempo per lasciarci covare (curare), cioè per ricevere questo Soffio infinito, o saremo i morti viventi che non a caso popolano film, serie, videogiochi e romanzi.
Senza cura la vita non ha senso, perché moriamo di fame (di tempo) e sopravvive solo il più forte, cioè chi mangia di più. Ma io non sopravvivo divorando gli altri, ma perché c’è un Soffio Curatore che mi ha voluto speciale: unico e irripetibile. E altrettanto unica e irripetibile voglio che sia la mia risposta, voglio sorprendere persino Dio, come un giardiniere si sorprende del fiore che sboccia anche se è lui stesso ad averlo piantato.
Ognuno di noi è chiamato a creare, con e per gli altri, ciò che solo lui può essere e fare, come mi diceva qualche giorno fa un’amica che si prendeva cura del suo bambino di dieci giorni, vincendo le leggi del tempo: «Ora c’è e ci sarà per sempre».
Il caos diventa Giardino.
Solo l’imprevedibile collaborazione con il Soffio (viene da dire che la vita è una co-spirazione per fare altra vita, la co-munità nasce da questo, vuol dire infatti dono, munus, comune), cioè nella Cura, dà respiro al mondo. Io, così limitato, desidero respirare il Respiro che cova il caos e lo rende vita, perché è Amore-Cura che trasforma me in Cura-Amore.
Attraverso di me, di noi, uniti in questo respiro, un pezzettino di caos (una classe, il bianco di una pagina, la paura della mia amata, il dolore di un amico) può diventare Giardino e il tempo moltiplicarsi come i semi nel frutto: in ogni ghianda c’è un bosco intero. Solo così mi sento Amato sulla Terra e Amante della Terra. E anche se, come nella canzone di Battisti, «l’universo trova spazio dentro me» però «il coraggio di vivere quello ancora non c’è».
Questo coraggio non è una magia, ma la Cura: una libera scelta di come vivere perché il mondo possa «venire al mondo». […] La cura fa fiorire il deserto e crea un mondo inatteso, sorprendente, vivo, bello.
O si divora o si cura: a ognuno di noi è chiesto di scegliere da che parte stare, non ci sono vie di mezzo per «respirare» e «far respirare» questo mondo.
E per poter dire, alla fine: nulla è andato sprecato, tutto il tempo che avevo si è trasformato in amore.
Tratto da
Alessandro D’Avenia in Corriere della Sera, Buone Notizie, 10/01/2023
RIEPILOGO DI UN ANNO CON LE CLASSI TERZE
E’ la volta delle classi terze. Se ci fossero problemi nella visualizzazione cliccare qui.
Riepilogo di un anno con le classi seconde
Ecco quanto è stato svolto con le classi seconde. PS Se dovessero presentarsi problemi nell’aprire la pagina, cliccare qui.
Riepilogo di un anno con le classi Prime
Pian pianino recupererò quanto ho svolto con le classi della scuola media. Inizio con le classi prime 😉. Se ci dovessero essere problemi per visualizzare la pagina, cliccare qui.
Prima che il nuovo anno arrivasse: lettera ad una nipotina (e non solo)
Di Elisa Manna in Avvenire del 1 dicembre 2022
Finalmente stai arrivando. Ed è una cosa “cosmica”: un momento che ha a che fare più con l’imponenza distante delle galassie che con i piccoli affanni e gioie quotidiane. Uno squarcio su un’altra dimensione così misteriosa, possente e altra da noi, eppure così vicina che possiamo sfiorarla. Un momento in cui sentirsi apparentati alle stelle.
Tra poco una Forza vitale sconosciuta comincerà a dirigere gli eventi come un direttore d’orchestra e in poco tempo sarai stordita dalla luce e dai suoni , voci rivolte a te che ti accolgono, stanche e felici.
Carissima Vittoria ti scrivo ora, perché poi i miei pensieri saranno certamente diversi e meno lucidi. Sei stata davvero una grande viaggiatrice e hai saputo percorrere tutte le tue tappe con tranquillità. Ma chissà se all’arrivo ci sono state solo stanchezza e fatica o anche qualcos’altro, magari la nostalgia della piccola casa accogliente che conoscevi…
Sai, il mondo che ti aspetta qui non è come te, tutta nuova: è un mondo vecchio che ha fatto già tanti sbagli. Si è ammalato, ormai ha la febbre e chissà se riusciranno a fargliela scendere. Era un paradiso terrestre, c’erano acque fresche e limpide e immensi ghiacciai ne custodivano il segreto vitale, candidi e purissimi. Il terreno era generoso e produceva delizie dal sapore oggi dimenticato, quando respiravi sentivi che la vita ti entrava nei polmoni, ogni giorno affrontavi il tuo percorso con animo forte e sereno, rassicurato da molte certezze. Le estati erano una festa per il cuore e per il corpo, un sole splendente che accarezzava la pelle e la confortava, donandole un caldo colore ambrato, mentre una lieve brezza la rinfrescava.
È vero, questa manna sparsa a piene mani non era per tutti ed esistevano tanti sfortunati anche in passato: ma il divario tra quelli che stanno bene e quelli che vivono negli stenti non era così ingiusto, odioso come adesso in cui imperatori del denaro non riescono più a immaginare come soddisfare nuovi capricci (un volo nello spazio per regalo di compleanno?) mentre folle immense di diseredati cercano di scampare alla fiamma di un sole diventato nemico nella loro terra, alla siccità senza scampo, alla fame, alle guerre.
Il Signore ci ha donato tutto per puro amore senza volere niente in cambio, e noi siamo stati capaci di rovinare quasi tutto e quasi irrimediabilmente.
Sai, siamo stati perfino capaci di inventarci divinità che vogliono che ci armiamo e ci uccidiamo l’uno con l’altro come se l’unico Dio che ha senso per noi non fosse l’Amore Assoluto. Ma non ti voglio rattristare con questi discorsi sul passato, io che sono la mamma della tua mamma, e debbo e voglio più di altri infonderti coraggio.
La vita che ti attende potrà essere veramente meravigliosa, malgrado la realtà concretissima dei problemi di cui ti ho parlato. Questo non è un pianeta sbagliato per venire al mondo, anzi; qui stiamo facendo anche progressi scientifici e tecnologici incredibili, e se non perderemo definitivamente la testa, ci aiuteranno a curare malattie, allungare la vita, contrastare la fame, assicurare giustizia sociale, rendere obsolete e inutili le guerre.
E poi, qui ti aspettano tua mamma e tuo papà, una culla d’amore, e tanti (i nonni, gli amici) che vogliono proteggerti e accompagnare, sorridendoti, il tuo cammino: un mondo che somiglia a quel paradiso terrestre di cui ti parlavo prima. Solo, più piccolo. Questo immenso vantaggio che la vita ti darà forse basterà a sé stesso. O forse, in virtù di quella “misteriosa e divina logica di restituzione” che a volte abita il cuore degli uomini, ti spingerà a guardarti attorno. Ed è di questo, in effetti, che ti volevo parlare dall’inizio.
Ti auguro di essere felice per tutta la vita, certo. Ma ti auguro anche altro: per esempio di essere una persona compassionevole. Noi umani “brilliamo” solo se interagiamo con gli altri, da soli siamo un piccolo faro spento. E poi ti auguro di essere una persona mai chiusa nei confini limitati del proprio io, ma aperta a “sentire” e ad accogliere gli altri.
Ti auguro di essere vera, sincera sempre, almeno con te stessa. Conoscere sé stessi è il grande segreto di un animo pacificato. Sii libera, rispetta te stessa e tutti, la tua dignità non ha prezzo. Non inseguire l’eccitazione della gioia a tutti i costi; a volte abbiamo bisogno anche di avversità per crescere…
Ti auguro di amare l’ossigeno di alta montagna, lo iodio frizzante del mare: fa che i tuoi pensieri siano attraversati dal vento che fa gonfiare le distese di grano dorato.
Accendi i tuoi talenti, “alza le vele” come esortava il tuo bisnonno Gennaro che del faro del cristianesimo ha fatto la costante ispirazione per i suoi romanzi; fa che i tuoi talenti risplendano e sappiano trovare nuove soluzioni e mai solo per te stessa. Troverai le tue strade, Vittoria Luce. Lasciati guidare dal nome che tua madre ha voluto darti, non accontentarti.
E tutti voi, nuovi nati che arrivate, non lasciatevi intimorire dalla complessità di quest’epoca nuova, crescete sereni, poi “prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”, come diceva Giovanni Paolo II. Almeno, provateci. Sappiate che la vita sarà fantastica se in tanti saprete sfuggire alla trappola dell’egoismo e costruirete insieme un dialogo vivo e intenso, generativo di una nuova civiltà in cui ognuno abbia cibo, dignità e rispetto.
E, soprattutto, siate contadini e coltivate la speranza.
Tema Seamless Keith, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso