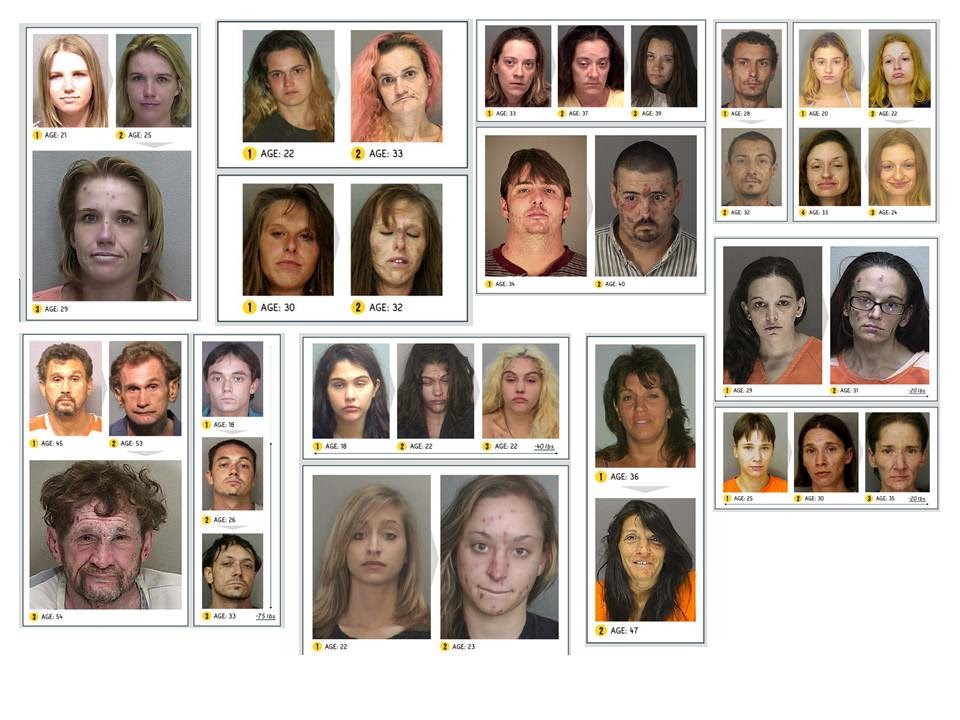I padri e le madri che hanno sconfitto l’odio
di Andrea Avveduto in Avvenire del 26 luglio 2014
Una madre israeliana scrive una lettera ai genitori di un giovane palestinese appena arrestato, messo in carcere perché solo pochi mesi prima aveva ucciso suo figlio David, di 28 anni. «Dopo che vostro figlio è stato arrestato – scrive Robi Damelin – ho trascorso diverse notti insonni chiedendomi cosa fare: far finta di nulla o cercare di trovare una strada per chiudere il cerchio? E poi ho deciso di cercare la via della riconciliazione ». La lettera di Robi venne pubblicata su Haaretz, il giorno di Yom Kippur, con il titolo: «Io l’ho perdonato». Quella donna coraggiosa aveva incarnato nella lettera lo spirito di Parent’s Circle, un’associazione nata esclusivamente dal desiderio di incentivare il dialogo tra israeliani e palestinesi. «Noi, che abbiamo perso i nostri figli nella guerra fra i due popoli, sosteniamo la pace. Noi, madri e padri, vogliamo arrivare a un accordo fra i due popoli, perché non accada più a nessuno quanto è successo ai nostri figli». Erano solo dieci nei primi anni Novanta, quando è nata l’associazione. Oggi sono più di seicento. Ogni giorno girano per le scuole, raccontano le loro storie di sofferenza, come quella di Robi e di suo marito, e soprattutto raccontano perché hanno scelto di perdonare. Storie che toccano i cuori. Come quella di Yitzhak Frankenthal , ebreo osservante e padre di cinque figli. Nel 1994 suo figlio Arik stava prestando il servizio di leva, quando un commando di Hamas lo sequestrò e lo uccise. Scartata l’idea di chiedere vendetta, il padre scrisse una lettera a Yitzhak Rabin, il primo ministro di allora, per chiedergli di raggiungere un accordo con i palestinesi. «La morte di mio figlio è avvenuta – scrisse al leader della Knesset – perché non avete ancora preso la decisione seria di fare la pace con i palestinesi». Il tono di questa lettera fu così commovente che Rabin – candidato al Nobel per la pace – chiese a Frankenthal di accompagnarlo a Oslo per assistere alla cerimonia di conferimento del premio. Nel corso degli anni le iniziative nate all’interno dell’Associazione si sono moltiplicate. «Way to recovery » è una delle ultime, nata per risolvere il problema degli spostamenti sanitari. Perché può capitare che un paziente palestinese riceva il permesso per curarsi in un ospedale israeliano, soprattutto quando le tecnologie palestinesi non permettono di affrontare adeguatamente il caso. Il problema è raggiungere l’ospedale. Le ambulanze dell’Autorità non possono in nessun caso varcare il checkpoint israeliano, ed è necessario che macchine con la targa gialla (israeliana) entrino nei territori per prendere il paziente e trasferirlo a Tel Aviv, Haifa o Gerusalemme. Per questo si è attivata subito una rete di volontari che ha messo a disposizione macchine e pulmini. Una spola umanitaria, che «prepara il terreno per costruire un rapporto più stretto tra i nostri due popoli», come dice Yuval Roth. «Dobbiamo partire dai gesti concreti per dimostrare che è possibile». Come accade nelle ambulanze gialle in giro per il Paese, dove le “donazioni incrociate” non guardano letteralmente in faccia a nessuno. Sangue palestinese per le vene israeliane e viceversa. In questi giorni di violenza le donazioni si sono intensificate, perché «con tutto il sangue che viene sparso, bisogna gridare al mondo che è più giusto donarlo ». Non importa se sono israeliani o palestinesi. Lo ha fatto scrivere anche Robi, sulla tomba di suo figlio David: «La terra è il mio luogo di nascita e tutti gli uomini sono miei fratelli». Lei che è «ebrea e israeliana. Ma prima di tutto un essere umano ».